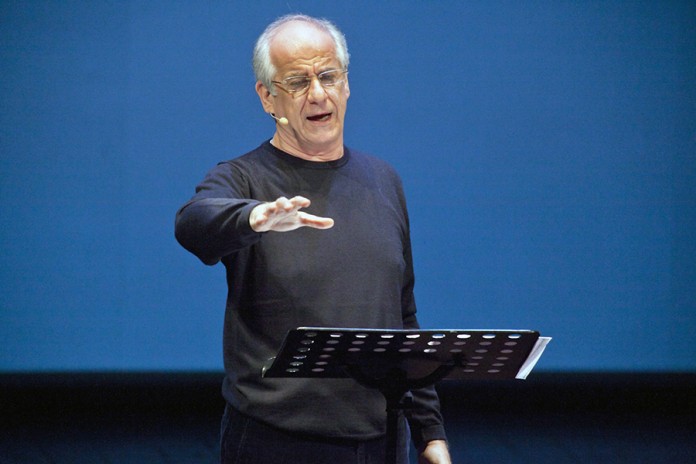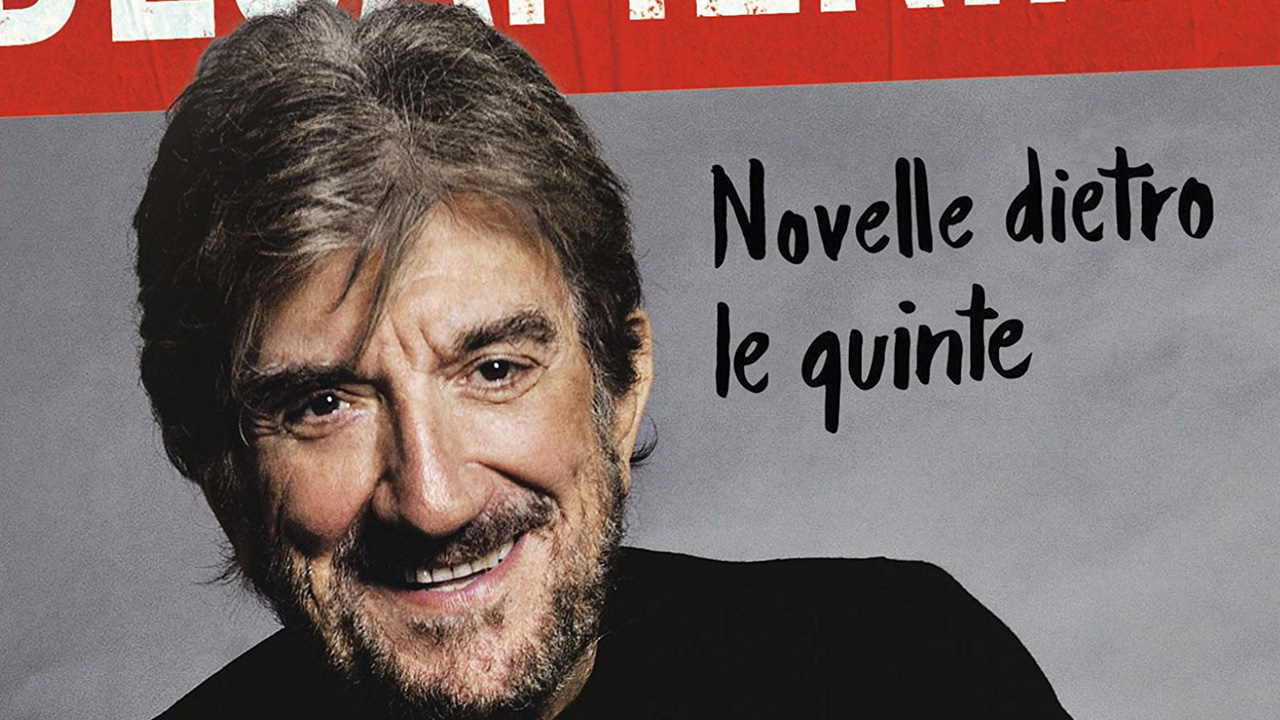Il Teatro Mercadante, deve il nome al musicista Fancesco Saverio Mercadante di origini pugliesi ma di formazione napoletana a cui fu dedicato il teatro nel 1870.
Il Teatro Mercadante fu costruito tra il 1778 e il 1779 dopoché, espulsi i gesuiti dal Regno di Napoli, i loro beni furono confiscati e andarono a costruire il “Fondo di separazione dei lucri” che decise di dar vita al teatro che prese inizialmente il nome di Teatro del Fondo.
Il Teatro Mercadante affaccia sull’antico largo del Castello Nuovo dove già esisteva il celebre teatro San Carlino, andato distrutto nell’800 insieme a baracche ed altre fabbriche fatiscenti per dare spazio alla piazza.
La facciata del Teatro Mercadante ripropone una composizione tipica dell’arte eclettica
La facciata ripropone una composizione tipica dell’arte eclettica con la ripartizione orrizzontale in tre ordini sovrastati da una sorta di timpano trapeiziodale; anche verticalmente risulta suddivisa in tre fasce da larghi pilastri leggermente a rilievo rispetto al fondo. I primi due ordini sono caratterizzati dalla presenza del bugnato e come il terzo possiedono un medesimo spartito delle bucature, tre al centro ed una su ciascun lato. L’ingresso tripartito è diviso da due colonne ioniche, utilizzate anche nelle bucature del secondo piano, mentre il terzo ordine è contraddistinto da otto statue di cariatidi, realizzate da Francesco De Matteis reggenti uno spesso cornicione merlato.
Il Teatro Mercadante nasce come Teatro del Fondo, dal nome di una società militare
Il Teatro Mercadante nasce come Teatro del Fondo, dal nome di una società militare (Fondo di separazione dei lucri) che mise in opera la struttura nel 1777-’78, con i proventi confiscati al Disciolto Ordine dei Gesuiti, affidandone la progettazione al colonello siciliano Francesco Securo. Nel 1779 inaugura con l’opera “L’infedele fedele” di Giovambattista Lorenzi, musica di Cimarosa.
Nel 1870 diventò Teatro Mercadante in onore dell’omonimo musicista pugliese formatosi a Napoli.
Dedicato particolarmente al genere operistico (“Opera buffa” e “Opera seria”), fu attivamente partecipe dei cambiamenti politici e culturali instaurati dalla Repubblica Partenopea (1799). In questo periodo diventò “Teatro Patriottico”, ospitando drammi e “Inni patriottici”, tra cui quello di Cimarosa, che costò al compositore la possibilità di rimanere a Napoli quando si restaurò la monarchia.
Con la Restaurazione il Mercadante recuperò la sua funzione operistica ed ospitò musicisti come Rossini, Bellini, Donizetti e Verdi. Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento ospitò la grande prosa italiana e internazionale: Adelaide Ristori, Fanny Sadowski, Ermete Zacconi, Eleonora Duse, Sarah Bernhardt e Coquelin furono gli acclamati protagonisti di quella fertile stagione, senza tralasciare i nomi di punta del teatro napoletano (Antonio Petito, Eduardo Scarpetta, Roberto Bracco), anch’essi molto seguiti dal pubblico. Teatro sempre rivolto alle novità, nel 1914 ospitò una discussa “Serata Futurista” organizzata da Marinetti. Successivamente suoi grandi protagonisti furono Marta Abba e Luigi Pirandello.
Tra il 1920 ed il 1938 ci furono lavori di restauro e nel 1936 il soffitto si arricchisce con un pregevole dipinto a tempera di Francesco Galante dal titolo “Napoli marinara”. Dopo ulteriori opere di restauro, dal 1959 al 1963 ottenne il riconoscimento di Teatro Stabile, sotto la direzione di Franco Enriquez. Nel 1963 si ebbe la chiusura per inagibilità, dovuta a ragioni statiche.
Il Teatro Mercadante sede dell’Associazione Teatro Stabile della città di Napoli
L’Associazione Teatro Stabile della città di Napoli nasce nel 2002 nel settecentesco edificio del Teatro Mercadante per iniziativa di Regione Campania, Comune di Napoli, Provincia di Napoli, Comune di Pomigliano d’Arco, Istituzione Comunale per la Promozione della Cultura della Città di San Giorgio a Cremano. Soltanto tre anni dopo, il 23 giugno 2005, ottiene il riconoscimento ministeriale di “Teatro Stabile ad iniziativa pubblica”.