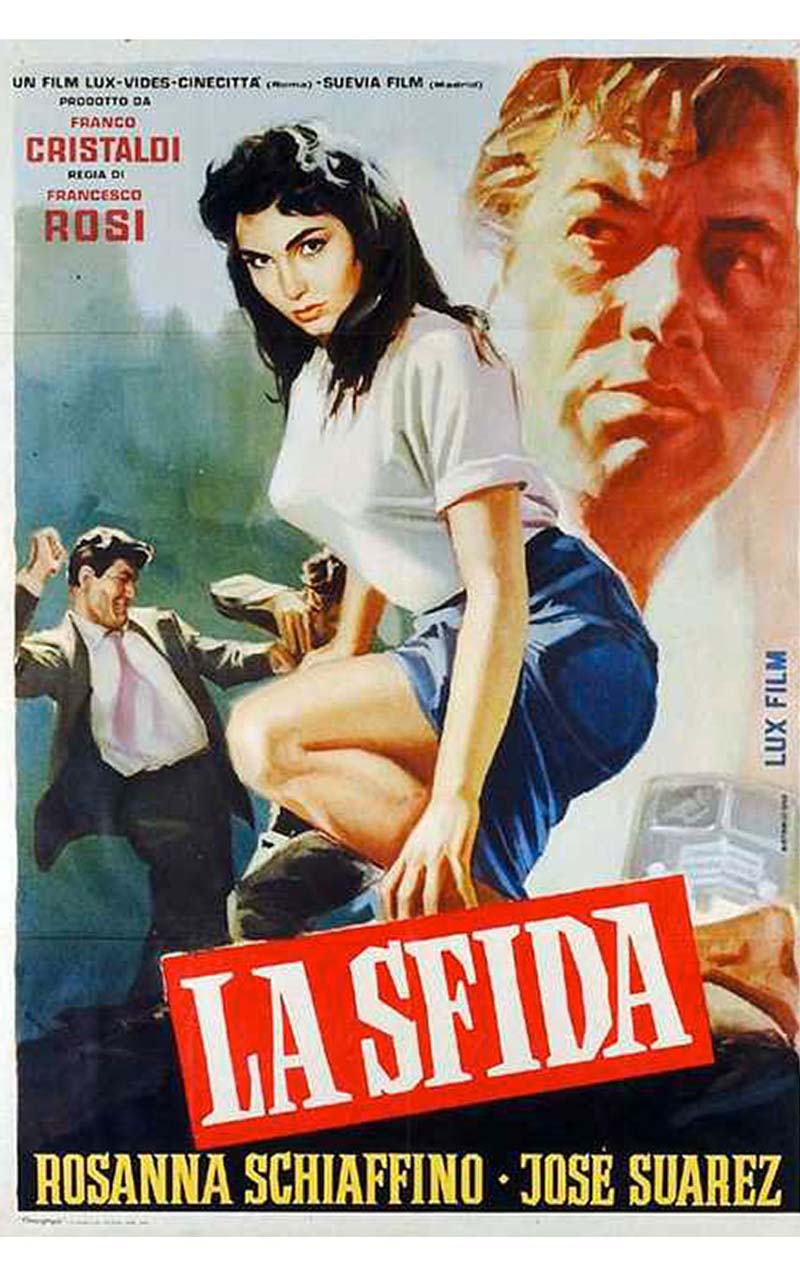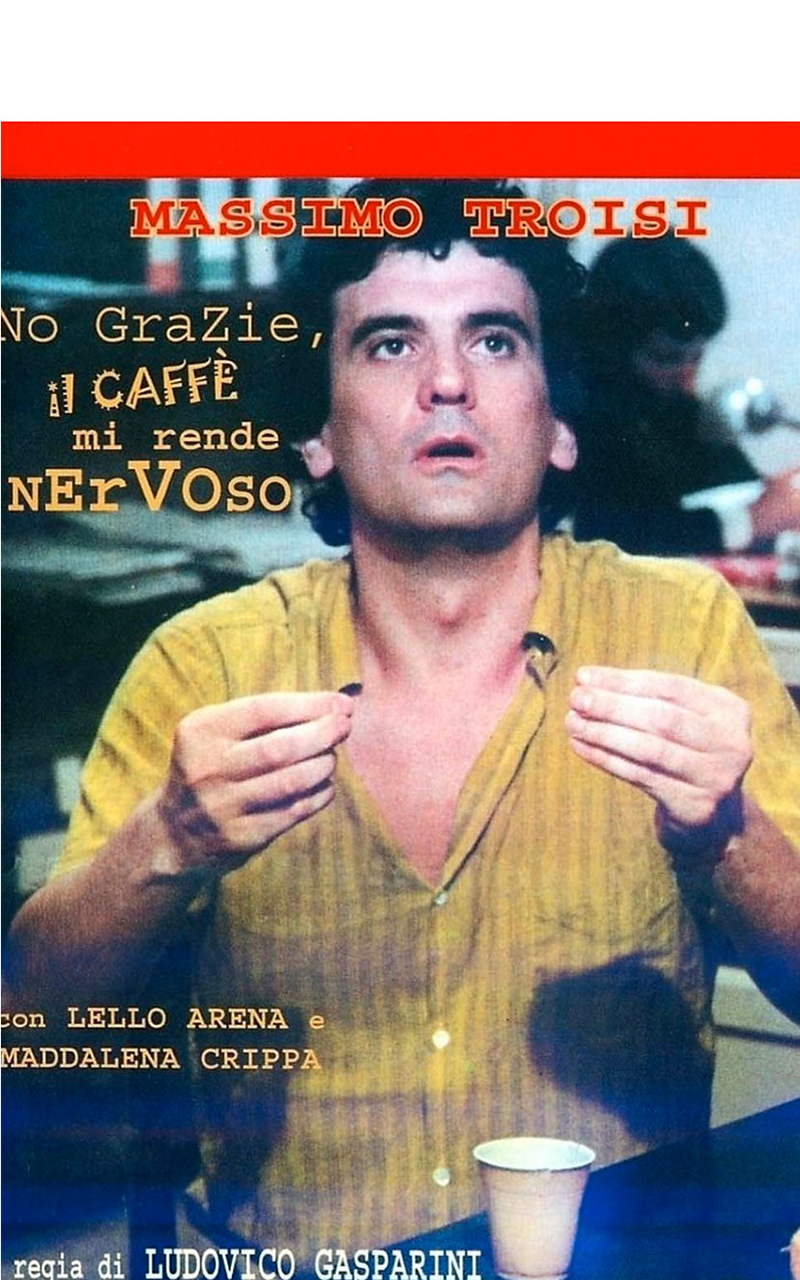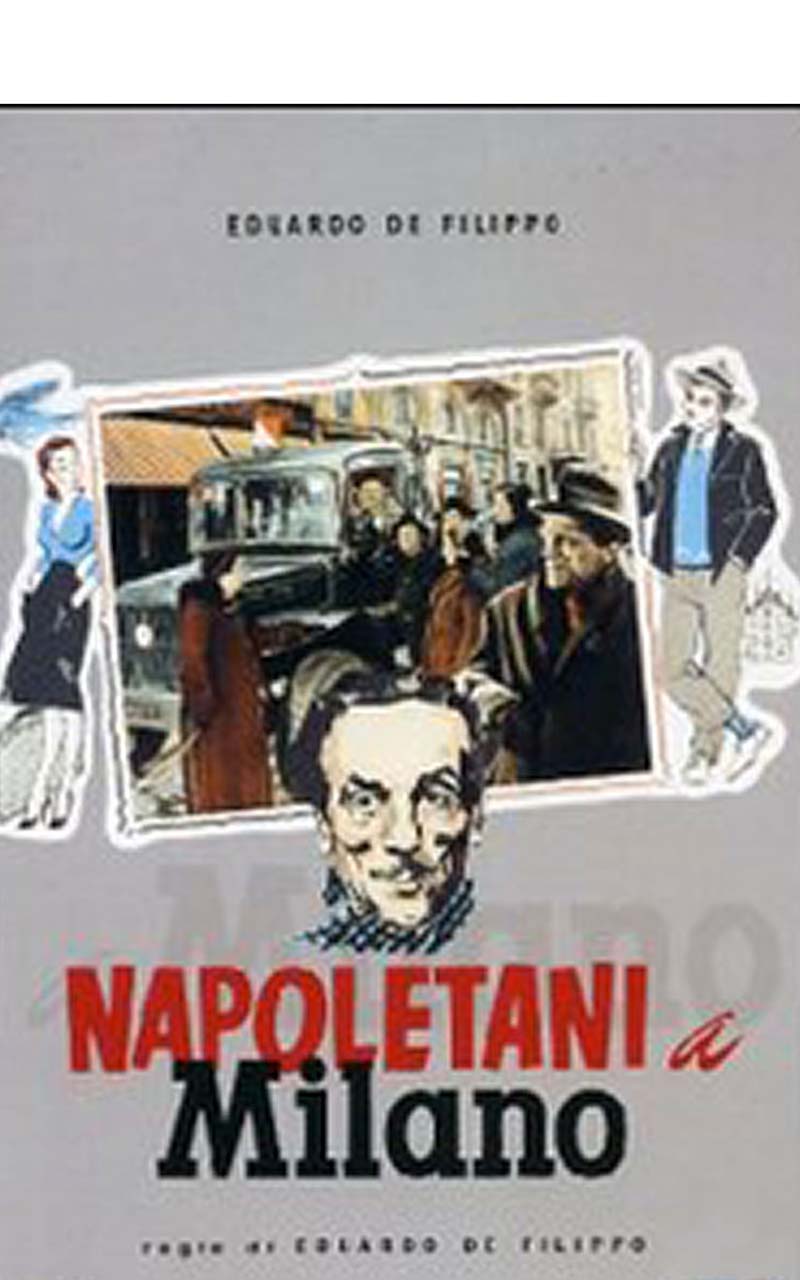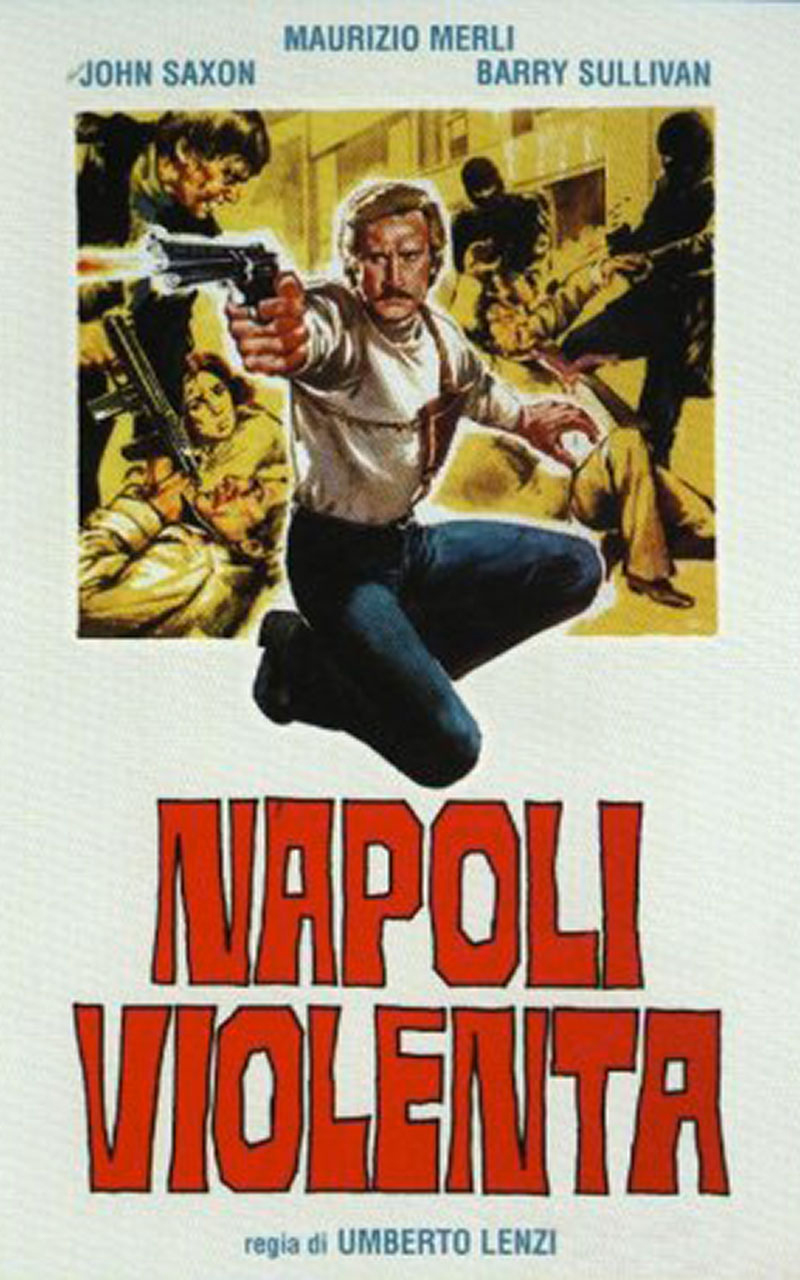L’oro di Napoli è un film del 1954 diretto da Vittorio De Sica.
L’oro di Napoli, diviso in sei episodi, è tratto dall’omonima raccolta di racconti di Giuseppe Marotta, che partecipa alla scrittura del film insieme a Vittorio De Sica e Cesare Zavattini. Nell’episodio Il guappo, il “pazzariello” Saverio è costretto a subire la convivenza del prepotente Carmine, che fa da padrone a casa sua; la presunta malattia del “guappo” gli dà la forza di liberarsene, ma questi ritorna quando scopre di non essere malato. La famiglia, tuttavia, trova il coraggio di cacciarlo definitivamente.
Nell’episodio Pizze a credito, Rosario, un pizzaiolo del rione Materdei, scopre con disperazione che la moglie Sofia ha perso l’anello prezioso che le aveva regalato.
Il pizzaiolo convinto che possa trovarsi in una delle pizze vendute, l’uomo fa il giro dei clienti, ignorando anche il “presunto” dolore di uno di questi, che è appena rimasto vedovo. L’anello è in realtà a casa dell’amante della moglie, presso il quale Sofia si era precedentemente recata; la donna riesce a evitare lo scandalo, facendolo passare per il cliente che lo ha trovato nella pizza acquistata.
L’oro di Napoli – I giocatori
Nell’episodio I giocatori, il conte Prospero si ritrova a sfogare il vizio del gioco, che lo ha rovinato, facendo delle partite di carte con un bambino, figlio del portiere; costretto dal padre ad assecondare la debolezza del nobile, tuttavia, il bambino lo batte continuamente, provocando le sue aggressioni morali.
L’oro di Napoli – Teresa
Nell’episodio Teresa, la protagonista Teresa, che fa la prostituta e vive in una casa di tolleranza in condizioni modeste, si ritrova proiettata verso una vita migliore con un matrimonio combinato da un intermediario; il marito, a lei sconosciuto, le rivela subito dopo i festeggiamenti di averla sposata, in realtà, per una scelta quasi casuale, pur di espiare la colpa di aver indotto al suicidio una giovane, che egli aveva rifiutato. Teresa scappa via per la rabbia, ma di fronte alla prospettiva di ritornare alla vecchia vita, ci ripensa e accetta di assecondare la finzione.
L’oro di Napoli – Il professore
Nell’episodio Il professore, Don Ersilio “filosofo” del vicolo e posteggiatore di sera, distribuisce a pagamento i suoi saggi consigli. Consultato dai suoi vicini del vicolo, che vogliono rispondere all’arroganza di un nobile, che per passare con la sua automobile ostacola le loro attività quotidiane, don Ersilio suggerisce una “terapia” di “pernacchi”.
Nell’episodio Il funeralino, per una donna a cui è morto il figlio più piccolo, il funerale rappresenta l’unica possibilità di riscattarsi dalla misera vita quotidiana.
L’episodio I giocatori de L’oro di Napoli è girato a Palazzo Pandola, uno dei set più ricorrenti del cinema napoletano. L’edificio che guarda su Piazza del Gesù Nuovo, diventa anche la casa di Filumena Marturano (Sofia Loren) in Matrimonio all’italiana.